Max Headroom-19. Il sogno del «distanziamento sociale» permanente nella propaganda post-coronavirus
- aprile 29, 2020
- in misure repressive, riflessioni
- Edit
di Wolf Bukowski, Con una postilla di Wu Ming sull’indossare la mascherina all’aperto.
INDICE
1. Un’idea paradossale
2. «La cosa più noiosa è già accaduta»
3. «Normalità» è un campo di battaglia
4. Pro tempore?
5. «Dobbiamo abituarci»
6. Procedere per sfoltimento di pubblico
7. Perché il capitalismo ci vorrebbe senza corpo, se guadagna anche sul nostro corpo?
8. Lo stato digitale
9. Di chi è la colpa? Tua!
10. Residuo organico
§. Postilla
Edison Carter è il reporter di punta della rete televisiva Network23. Almeno fino a quando non gli viene la pessima idea di indagare sugli effetti letali degli spot messi in onda dalla sua stessa emittente. Il crudele CEO della rete decide allora di eliminarlo, sguinzagliandoli dietro due sgherri. Nel corso dell’inseguimento la moto di Carter si impenna, e il reporter sbatte la testa contro una sbarra che segnala l’altezza massima per i veicoli in transito. A quel punto il corpo agonizzante di Carter viene consegnato al genietto amorale che sviluppa il software di Network23, che ne scansiona il viso e – in modo un po’ grezzo – le sinapsi in modo da poterlo mandare in onda, in simulacro elettronico, nonostante fosse (quasi) morto:
«il suo cervello […] è solo un banalissimo computer, una lunga serie di comuni interruttori […]. Io sono in grado di generare di nuovo quest’uomo sul mio computer, così lui potrà continuare il suo programma e nessuno lo scoprirà […]. Per ora sto immagazzinando solo i dati per creare una testa, ci vogliono troppi dati per creare tutto il corpo, che comunque non ci serve».
Poi le cose prendono un’altra piega, Carter ribalta la prognosi infausta e si rimette in piedi, prova le sue accuse al Network e ci accompagna a un happy end nel segno del realismo capitalista: il più umano tra gli squali in cravatta del consiglio d’amministrazione della rete prende il potere.
Parallelamente a questo sviluppo narrativo, il personaggio televisivo creato a partire dalla testa di Carter rimane attivo, e si dimostra perfetto come presentatore di videoclip musicali. Poiché nei primi inceppati momenti di funzionamento ripeteva l’ultima cosa letta da Carter prima dell’incidente, quell’altezza massima scritto sulla sbarra, viene battezzato Max Headroom. Questo, per sommi capi, il plot del film del 1985 che forniva il background al presentatore finto-digitale che di lì a poco avrebbe debuttato nella tv britannica.
In Italia Max è comparso in programmi televisivi nella seconda metà degli anni Ottanta, tra un videoclip e l’altro, nonché come protagonista di quello di Paranoimia degli Art of Noise. Quando mi capitava di vederlo – ero ragazzo, avrei dovuto essere precisamente il suo target – non lo sopportavo. Ciò che mi sfuggiva era che probabilmente Max era stato concepito proprio per risultarmi insopportabile. In una conversazione del 2015 i suoi creatori ricordano infatti di aver lavorato su varie ipotesi di cosa mandare in onda tra uno e l’altro di quegli «incredibili videoclip» e di avere scelto, infine, l’idea più paradossale. Dice Rocky Morton:
«Qual è la cosa più noiosa che potevo fare solo per infastidire tutti? La cosa più noiosa che mi è venuta in mente, del tutto controcorrente per la generazione MTV… era una testa parlante: un uomo bianco di classe media in abito scuro, che parlava loro in modo noioso».
2. «La cosa più noiosa» è già accaduta
In questi giorni molte teste parlanti ci hanno ripetuto che dobbiamo ritenerci fortunati di poter vivere un’esistenza online quale simulacro di socialità durante il lockdown. In realtà, come nota incidentalmente Ginevra Bompiani, le serie TV, il telelavoro, i webinar, le videochiamate… ne sono state la precondizione: senza di essi «non sarebbero mai riusciti a tenerci rinchiusi». Un lockdown di tale portata è divenuto pensabile dai governi perché quegli strumenti digitali erano già disponibili. E non, al contrario, quegli strumenti hanno semplicemente reso più sopportabile illockdown. Scomodando Gramsci,
«Non è la semina regolare del frumento che ha fatto cessare il nomadismo, ma viceversa, le condizioni emergenti contro il nomadismo hanno spinto alle semine regolari ecc.» (Q 7 § 35)
e parafrasandolo (con una certa dose di arbitrio, ovviamente):
Non è il lockdown che ha smaterializzato i rapporti umani, ma viceversa, sono le preesistenti condizioni di smaterializzazione (dettate dalle esigenze ideologiche e di profitto) che hanno reso possibile il lockdown.
Se questa ipotesi è vera, ne deriva che non esistono più caratteristiche intrinseche alla collettività che ne impediscano la chiusura in casa per lunghi periodi emergenziali; e dunque la politica futura, di fronte a un’emergenza, si interrogherà sistematicamente sul se dichiarare un lockdown o meno. Quanto detto vale sia su un piano di tenuta sociale che su quello economico. È vero che le condizioni di vita di milioni di persone usciranno letteralmente devastate dal lockdown, ma c’è da tenere presente che ci sono, al contrario, settori economici che ne saranno darwinianamente rafforzati, e quei settori sono tra quelli che, senza neppure alzarsi in punta di piedi, anzi flettendosi un poco, sussurrano istruzioni alle orecchie di ministri e politici. Telecomunicazioni, logistica, intelligenza artificiale, GDO, «sicurezza» cioè guerra. Sono settori che in questa fase hanno goduto – ognuno in proporzioni differenti – sia del confinamento di milioni di persone sia delle ampie eccezioni al confinamento previste per lavoratori addetti alle più diverse mansioni.
Se dunque non esistono più caratteristiche intrinseche alla collettività che ne impediscano la frammentazione domiciliare per lunghi periodi d’emergenza, e se il lockdown ha influenti vincitori, significa che il confine tra «eccezione» e «normalità» si è già spostato definitivamente. L’«eccezione» resta tale, ma è un pochino più normale. La «normalità» non sarà certo quella dei giorni di confinamento ma nondimeno incorporerà, d’ora in poi, anche la possibilità di un reiterato #iorestoacasa.
3. «Normalità» è un campo di battaglia
Ne La danza delle mozzarelle (2015) avevo registrato l'(ab)uso del concetto di «normalità» nella politica contemporanea a partire dal suo contrario, ovvero l’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam quale livre de chevet del Cavaliere, prefato e pubblicato da sé stesso (Silvio Berlusconi Editore) nel 1992. Per non parlare poi della categoria di foolishness utilizzata da Steve Jobs nella costruzione del feticcio della merce digitale Apple.

«Non usate questo cervello!» (Frankenstein Junior di Mel Brooks, 1974).
Dall’altra parte un pedante D’Alema riusciva persino a intitolare Un paese normale il suo libro del 1995, e quella «normalità», ça va sans dire, era la piena adesione del partito ex comunista alla dottrina neoliberale. A movimentare il quadro, anni dopo, aveva pensato il duo involontariamente comico Matteo & Oscar alla Leopolda del 2013:
Renzi: «Farinetti ha detto che lui crede in me perché io sono matto […].»
Farinetti: «Sì è vero, ti considero matto. [Un] matto simpatico, [un] matto proattivo, […] il matto opportuno in un momento in cui serve un matto, per cambiare le robe e farle ritornare normali… Perché il grande tema sapete qual è? Essere matti per ritornare alla normalità. Sembra un paradosso ma la grande scommessa dei prossimi mesi, dei prossimi anni è questa».
Dunque non da oggi la definizione di «normalità» è un campo di battaglia. Dire che la «normalità» del capitalismo ci fa schifo è sacrosanto, ma considerare l’evento virale e le sue conseguenze sociali – mediate politicamente – l’«anormalità» che consentirebbe il balzo di tigre della critica radicale è un’intenzione nobile ma zeppa di idealismo. Anche perché prima, appunto, va riportato il concetto di «normalità» ai suoi contraddittori elementi costitutivi.

Paskedda Zau, protagonista dei moti iniziati il 26 aprile del 1868, reinterpretata in chiave manga nel 2019 a Nuoro.
I rivoltosi e le rivoltose che nella Sardegna del 1868, colpita dalle privatizzazioni delle terre, si battevano per tornare a su connottu, cioè «il conosciuto» e quindi il «normale», erano forse dei reazionari? Al contrario: la loro lotta esprimeva le ragioni dell’umano contro quelle del capitale e delle istituzioni coloniali italiane. C’è quindi una «normalità» da combattere e una da salvare, e il discrimine è nella scelta di campo (di classe) che si opera. Da sempre è così, ed così è anche oggi. Torno a citare un passaggio di Marco Bascetta che è già stato richiamato, per la sua nitidezza, su queste pagine:
«Qualcuno valuta con speranza l’impossibile ritorno alla “normalità”, poiché questa era contrassegnata da ingiustizie, diseguaglianze, sfruttamento. Ma […] “normalità” ha anche un altro irrinunciabile significato[…:] la natura sociale, relazionale, affettiva, corporea, sensibile, dell’animale umano. La sua propensione ad attraversare situazioni e ambienti sempre diversi e a sperimentarvi tutti i suoi cinque sensi. […] Che la dimensione telematica possa riassorbire e restituire tutto questo, o anche solo surrogarlo pro tempore è più che una cattiva utopia, una triste illusione.»
4. Pro tempore?
Se lo spettro, e l’ipotesi concreta, del lockdown attraverserà il nostro futuro, dobbiamo farci da subito una domanda essenziale: quali delle sue caratteristiche sono occasionali e quali permanenti? Il confine tra «normalità» ed «eccezione» si è spostato come detto, ma dove si trova adesso?
Attorno a questo tema un ampio schieramento di soggetti sembra desiderare, o semplicemente ritenere ineluttabile, che il veleno del «distanziamento sociale» debba essere assunto per sempre. Questo schieramento è composito, opera per approssimazioni successive, frasi buttate lì con nonchalanche e tecnica del patchwork, ma infine converge nell’affermare che «nulla sarà come prima», e ogni volta che lo dice produce uno slittamento dal pro tempore al definitivo. Alcuni esempi chiariranno, spero, ciò che voglio dire.
Il primo esempio si trova nelle vostre caselle mail, se siete lavoratori o lavoratrici. I messaggi che lo illustrano provengono da superiori, dirigenti, capetti e capette eccetera. Queste mail contengono l’annuncio della sperimentazione di qualche nuovo «servizio online» ai clienti, e la frase chiave è quella che suona più o meno così: «questo servizio ci consente di far fronte al meglio all’emergenza e di sperimentare modalità innovative di relazione con il cliente da sviluppare in futuro». Et voilà, non viene neppure nascosto. Se al capitale – e alle istituzioni pubbliche che operano in modo manageriale e privatistico – piacerà spingere sul pedale della smaterializzazione delle esistenze lavorative, potrà farlo più di prima senza timore di opposizioni, ché il veleno è stato inoculato mentre i lavoratori erano costretti in casa, grati del fatto di avere, nonostante tutto, uno stipendio.
5. «Dobbiamo abituarci»
Il secondo esempio è più sofisticato, e ha a che fare con la costruzione dell’ideologia di un’esistenza digitale. Se ne incarica, nel caso che presento, il filosofo Davide Assael nella puntata del 18 aprile di Uomini e Profeti (Radio 3), nel corso della quale ci informa che è tempo di
«superare un pregiudizio […]: che la relazione vis-à-vis sia una relazione più autentica in quanto ci mette a contatto con un corpo e un volto, come se il corpo nella relazione vis-à-vis fosse inteso come dato di natura, che si offre sic et sempliciter alla nostra esperienza. Ma non è affatto così! Niente di più ingenuo! Il corpo è sempre una costruzione culturale e lo capiamo benissimo, perché noi attribuiamo certi significati a una postura, a un’espressione del volto, a uno sguardo, ma è chiaro che questi significati sono dei costrutti sociali: la stessa espressione può avere un significato in un paese e un altro significato dall’altra una parte del mondo!»
Si tratta di una forma mentis assai promettente per questi tempi, che permette l’uso regressivo di concetti che hanno avuto una funzione liberatoria.
Il fatto che la partita sul corpo sia una partita culturale ha consentito infatti di affermare che le oppressioni del corpo e dell’orientamento sessuale basate sulla normatività bianca e patriarcale sono oppressioni culturali e quindi non naturali. Detto in altri termini: riconoscere il corpo come costrutto culturale permette di dire che l’umano non è rappresentato interamente dagli uomini su cui è modellato Max Headroom (maschi bianchi occidentali eterosessuali e ben vestiti), ma è un campo infinitamente più ampio, variegato e felicemente attraversabile.
Qui, invece, si usa lo stesso ragionamento ma per fare apologia della liquefazione dei corpi nella dimensione digitale. Dimensione che però non mette affatto al riparo dal riprodursi delle ben conosciute gerarchie di razza, genere, classe, orientamento sessuale…Una conoscenza anche solo superficiale dei processi reali con cui la digitalizzazione intrappola corpi e destini delle persone consente di capire come ciò avvenga: nell’accesso ai procedimenti burocratici online, nell’apprendimento, nella sovraesposizione di alcune categorie e nella invisibilizzazione di altre, nella qualità e nel prezzo dei percorsi e prodotti digitali disponibili, eccetera.
Ma soprattutto emerge, qui e là nell’intervista, l’uso reiterato dell’espressione «dobbiamo abituarci», ed è con questa espressione che viene operato il completo ribaltamento della tesi apparentemente sostenuta. Il corpo è costrutto culturale, dice Assael, e proprio in virtù di questo «dobbiamo abituarci» al fatto che sia digitalmente fungibile; ma è l’istanza del «dobbiamo abituarci» che, a sua volta, non viene presentata come costrutto culturale diventando così, implicitamente, un dato di natura. Ne deriva così che tutto è cultura tranne, guarda caso, quello che più precisamente determina ciò che siamo autorizzati a fare proprio del nostro corpo!
Voglio qui evitare ogni possibile fraintendimento: il problema di questo approccio – quello di Assael è solo un esempio tra mille, ovviamente – è che il suo raggio di azione non sembra essere quello della presente condizione di confinamento o delle fasi immediatamente successive, fino a conclusione della virulenza pandemica, alla produzione di un vaccino efficace, ecc. No: non si dice, infatti: «dobbiamo stringere i denti», «dobbiamo avere pazienza», «adda passa’ ‘a nuttata» – cosa che potrebbe essere ragionevole e condivisibile –, ma si utilizza invece il «dobbiamo abituarci» o il «nulla sarà come prima». Lo si fa con abbondanza e, nei casi dei datori di lavoro, con voluttà.
6. Procedere per sfoltimento di pubblico
Come dice con grande naturalezza, come dandolo per scontato, l’architetto cinefilo Giorgio Scianca, la fruizione delle sale cinematografiche cambierà per via di
«tutte queste nuove regole che ci dovranno essere nell’immediato ma che poi diventeranno anche, forse, un nuovo modo di vivere l’esperienza cinematografica».
Le sale cinematografiche a norma di distanziamento devono essere anche «belle», continua l’architetto, rivelando così di pensare che le norme di distanziamento fisico saranno durature almeno quanto una ristrutturazione o nuova costruzione edilizia. E quindi, di nuovo, il messaggio che passa, al di là delle intenzioni dei singoli parlanti, non è quello di sopportare ancora un po’, ma quello di avvezzarci al distanziamento eterno e ad accettarne le norme come ineluttabili, nonostante la devastazione sociale che porteranno.
Se i cinema, infatti, avranno la metà o un terzo dei posti, quanti di essi resteranno aperti, e quanto costerà il biglietto? La risposta è semplice: solo le multisala di catena sopravviveranno, e i biglietti dovranno coprire i mancati profitti delle poltroncine mancanti. Come nota Giovanni Semi in un’intervista a Zero:
«La soluzione classista che si fa strada per il settore culturale è emblematica: non potendo garantire assembramenti si procede per sfoltimento di pubblico; non potendo sbigliettare per mille persone, lo si fa per 100 facendo pagare quel biglietto molto di più, mentre altri gli si garantisce la diretta streaming a basso prezzo; l’aristocrazia che torna a prendere possesso dei teatri e della cultura e il popolo che se lo guarda in streaming nella smart city. […] Ci sarà, quindi, una selezione molto violenta.»
Certo, a fronte della devastazione di interi settori economici, e cioè dei soggetti più deboli che vi lavorano, se ne apriranno di nuovi. Ma, proprio perché saranno settori in gran parte parte digitalizzati, essi concentreranno la ricchezza con la voracità con cui un buco nero concentra la materia. Si pensi, per restare alla produzione culturale, alle piattaforme dell’intrattenimento.
7. Perché il capitalismo ci vorrebbe senza corpo, se guadagna anche sul nostro corpo?
Ipotizzo qui per comodità un’obiezione omnibus, così da rispondere da subito ad alcune questioni: «stai dicendo che il capitale ci vorrebbe confinare dietro a uno schermo, ma se Confindustria non fa altro che spingere per riaprire le attività economiche il prima possibile, manifestando anche un certo cinismo?»
Una prima risposta è quella già contenuta in quanto già detto: ci sono player che usciranno vincenti dal lockdown e dalle fasi successive (fase 2, fase 3… fase ∞).
Inoltre: Confindustria non è il capitalismo, e dopo l’uscita di Fiat/Fca non rappresenta neppure del tutto il capitalismo italiano, che nel frattempo non è neppure più italiano… Quindi insomma il potere di Confindustria, come si è visto in queste settimane, è piuttosto ridimensionato: è in grado di ottenere generose dazioni dal governo, ma forse non di orientarne fino in fondo le scelte.
Ma soprattutto: il capitalismo è un complesso di rapporti sociali, attraversati da tendenze generali ma anche da tensioni complementari e in competizione tra loro. Vi sarà quindi sempre un capitalismo che guadagna coi corpi: lo sfruttamento dei rider, per fare un esempio vistosissimo, non è mai cessato, e questi lavoratori oltre a dover pedalare sono stati pure colpevolizzati dai volontari della delazione e dai giornali di destra.
Si tenga poi presente che il rider è già ora un’interfaccia biologica tra ciò che avviene digitalmente sullo smartphone del vorace cliente, il terminale presso la cucina e il server della piattaforma che estrae gran parte del profitto dal complesso di queste operazioni. Il corpo del rider è quindi già un corpo attraversato dal digitale.
Infine: la necessità di avere lavoratori presenti al lavoro non è affatto in contraddizione con quella di confinarne altri al telelavoro domestico; anzi questo trattamento divide lungo nuove linee il mondo del lavoro, e si aggiunge alle divisioni già presenti (tra autoctoni e immigrati, dipendenti e finte partite Iva, stabilizzati e precari…). Si potrà usare così, more solito, questa nuova frattura come modalità per generalizzare riduzioni di salario.
Per esempio: chi sta a casa non consuma benzina o abbonamenti dei mezzi pubblici per andare al lavoro, e quindi in contratti di nuovo tipo si potrà immaginare un salario proporzionalmente ridotto; poi si lascia sedimentare un poco la situazione e di seguito si dirà a chi lavora in presenza: «ehi tu, il tuo stipendio è spudoratamente altorispetto a quello di chi sta a casa, cominciamo a tagliare su questa e quella indennità».
A quel punto l’informazione e la politica «scopriranno» che chi sta a casa deve pagarsi da solo riscaldamento e tirate dello sciacquone, si solleverà un po’ di polvere dicendo che è un’ingiustizia, ma dopo qualche giro di valzer le aziende cominceranno ad addebitare a chi sta in fabbrica una quota dei costi dell’acqua, del gas e della pulizia del cesso. E questo per «equità», naturalmente!
Fantapolitica? No, ho soltanto riprodotto su situazioni ipotetiche la dinamica che investe il mondo del lavoro da trent’anni a questa parte, fatta di equità-al-ribasso, situazioni lose-lose per i lavoratori e concorrenza calata dall’alto.

Beppe Sala paladino-della-salute, in nome del «distanziamento sociale», si batte oggi per l’ampliamento degli orari dei negozi, in perfetta continuità con Beppe Sala apologeta-del-consumo, che si batteva ieri… per la stessa identica cosa.
Nondimeno resto convinto che tra queste tensioni contraddittorie del capitalismo quella prevalente è quella che spinge verso il telelavoro, e non è difficile dimostrare perché. Qualcuno pensa forse che il lavoro agile sarà per sempre, come per molti è in questi giorni, il semplice stare a casa con il proprio stipendio intero ad aspettare per otto ore che compaia sullo schermo qualcosa che si possa fare online, trovandosi così spesso con un carico di lavoro ridotto? Qualcuno pensa dunque che lo smart, cioè il furbo, dello smart working sia il lavoratore? Se sì, sbaglia di grosso.
La smobilitazione del lavoro in presenza che si perseguirà nel post-epidemia – fase 2, fase 3, fase ∞… – prelude a una trasformazione epocale dei rapporti contrattuali, che passeranno in modo generalizzato da quelli basati sulle ore di presenza – che consentono una certa dose di autodifesa dei lavoratori nei confronti dei carichi eccessivi – a quelli basati sul risultato, ovviamente deciso e prezzato in modo unilaterale dal datore di lavoro. Lo smart working è per sua natura lavoro a progetto, e il lavoro a progetto è trionfo del capitale contro i lavoratori. Un’amica, da un paese dove il lockdown è meno duro ma la devastazione dei rapporti di lavoro più avanzata, mi ha scritto:
«A differenza che in Italia qui non c’è un clima poliziesco, tutti bene o male escono a fare passeggiate e per ora non ho sentito di nessuno che ha preso multe. Il problema è il lavoro, non ci sono più confini e ci fanno fare i turni per lavorare anche nel fine settimana. Senza avercelo chiesto: è stato imposto».
Inoltre, non è neppure il caso di spiegare perché e come, la frantumazione fisica dei luoghi di lavoro genera impossibilità dell’azione sindacale, oltre ad aprire mercati digitali infiniti per la socialità perché il luogo di lavoro è – nonostante tutto – anche un luogo di socialità. Da ognuno di questi mercati digitali, nuovi o implementati (app di dating ma anche app per amicizie e app per prendere caffè virtuali alla macchinetta), il capitalismo digitale sempre più concentrato e quindi coordinato potrà estrarre dati per profilazione, eccetera.
8. Lo stato digitale
Lo stato, per parte sua, ha almeno due motivazioni decisive per spingere verso la smaterializzazione dei rapporti di lavoro e sociali. La prima è l’assoluta subalternità della classe dirigente alle istanze del capitalismo digitale. Nel mondo della scuola questo fenomeno è particolarmente vistoso. Come racconta qui la Rete Bessa:
«Vado sul sito del ministero dell’istruzione e […] clicco […:] sono elencate tre piattaforme. Google, Microsoft, Amazon. Tre enti privati tra i più potenti al mondo schiaffati in bella mostra.»
Su Jacobin Lorenzo Mari ricostruisce il dibattito statunitense sulla penetrazione della Silicon Valley nell’istruzione e sul suo orientarla alla creazione di «lavoratori competenti» piuttosto che a «soggetti conoscenti», che è poi obiettivo assai prossimo a quello perseguito dalla UE con la sua «didattica per competenze». E ancora: la PA continua a dotarsi di software proprietari, consolidando rapporti di «scambio» tra basso costo del servizio e la predazione dei dati degli utenti (che essendo utenti o lavoratori di PA non possono neppure sottrarsi). La scelta di Vittorio Colao, ex manager di Vodafone, a capo della task force che ha di fatto rimpiazzato il parlamento italiano, conferma la centralità della relazione tra stato e aziende di TLC e digitale.
Ma c’è una seconda macroscopica motivazione per cui lo stato spinge verso una società il più possibile smaterializzata. La digitalizzazione è controllo, e lo è fin dalle sue origini. Negli anni novanta, proprio mentre la rete internet sembrava promettere di dispiegare nella società un potenziale liberatorio, il dipartimento di polizia di New York, sindaco Rudy Giuliani, intrecciava la brutalità fisica della Tolleranza Zero all’introduzione massiccia del digitale. Nella war room del NYPD, settimana dopo settimana, Bill Bratton incontrava i commissari di distretto e li strigliava o lodava in base ai dati di Compstat, il software in cui veniva inserito e rielaborato ciò che era stato fatto ai corpi (arresti, perquisizioni, controlli…), rendendo così il razzismo e il classismo di quel modello di ordine pubblico assai più efficace. Fin dai primi anni della sua applicazione sistematica, dunque, il digitale è legato (anche) a una cattura del corpo. Da subito in senso proprio, poliziesco; e di seguito anche antropologico, come possiamo osservare nella costruzione di schemi comportamentali e persino di posture fisiche determinate dall’uso dei device.
Ogni mediazione tecnologica nei rapporti umani è quindi gradita allo stato almeno quanto è gradita alle aziende del digitale, e la probabile volontarietà della app Immuni è solo uno scampato pericolo momentaneo: la stessa idea ampiamente circolata che potesse diventare obbligatoria – con tanto di «braccialetto» elettronico ipotizzato per non possiede uno smart – fa sì che al prossimo giro un governo potrà effettivamente renderla tale; e di seguito lo slittamento lambirà ineluttabilmente il territorio dell’uso poliziesco dell’app sanitaria. D’altra parte: se si usa la polizia per combattere una pandemia, perché non usare una pandemia per combattere il crimine (compreso, sia chiaro, il dissenso politico criminalizzato)?
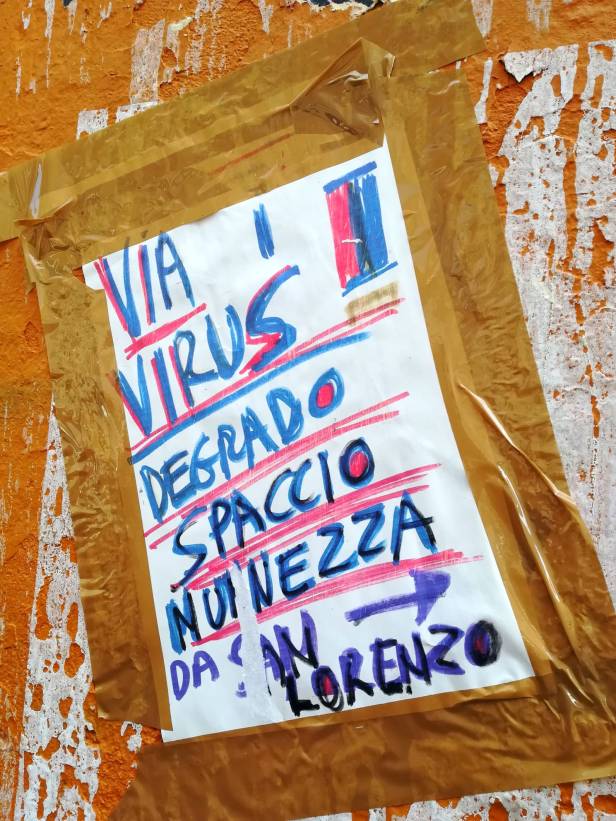
Immagine da Studi sulla Questione Criminale.
9. Di chi è la colpa? Tua!
«Il bug dell’app è concettuale, non tecnico», dice il collettivo Ippolita in un’intervista raccolta da Leonardo Filippi:
«perché si ritiene che la prevenzione sanitaria possa essere garantita da una applicazione su un telefono cellulare? La app sarà soprattutto l’ennesimo “diario” da riempire di informazioni, in questo caso riguardanti la “percezione” che si ha della propria salute. Siamo ancora nell’illusione che attraverso il racconto di sé, la tecnologia possa prendersi cura di noi […]. La prevenzione non si fa con gli algoritmi, ma con la diffusione di pratiche anti-infettive condivise in un network fisico di luoghi e persone.»
La «diffusione di pratiche anti-infettive condivise», ovvero una responsabilità che ci si assume nei confronti di sé e degli altri, modulata in base al contesto e fatta di prassi concrete, si trova agli antipodi del tipo di «responsabilità individuale» che viene costantemente evocata dall’inizio di questa crisi, fondata invece sul rispetto «responsabile» di norme spesso prive di ogni ratio, come – ne parlano ancora una volta i Wu Ming nella postilla qui sotto – l’obbligo di mascherina all’aperto o il divieto di sport individuale).
Quello che emerge è un doppio legame schizofrenico per cui la persona non viene messa in grado di esercitare la propria responsabilità, ma allo stesso tempo viene costantemente richiamata alla «responsabilità» nell’ottemperare a regole pensate con scopi teatrali (vedi postilla). Questa enfasi sulla parte fittizia della responsabilità individuale (sulla parte insomma che prevede una responsabilità senza scelte) è particolarmente perniciosa.
Riavvolgiamo infatti un momento il nastro: se ce lo ricordiamo, il ricorso al lockdown è stato motivato con l’insufficienza dei posti in terapia intensiva. Abbiamo visto fin qui impegni precisi, vergati a penna e sottoscritti su un modulo di autocertificazione irrevocabile firmato Conte & C., a proposito di un adeguamento strutturale (non propagandistico o emergenziale) di quel numero di posti in terapia intensiva e del personale sanitario addetto? No, però abbiamo avuto appelli alla nostra responsabilità e tante evocazioni di possibili ulteriori lockdown, al punto che il sospetto viene: non è che il lockdown, il «nulla sarà come prima» e la responsabilizzazione individuale dei governati possano fungere ancora una volta come deresponsabilizzazione dei governanti?
Così funziona infatti da decenni: se i trasporti pubblici sono inadeguati, si dice, non è colpa della classe politica che li ha sottofinanziati ma di «quelli che viaggiano senza biglietto»; se i braccianti sono sfruttati a cottimo non è colpa dei giganti della filiera ma di chi compra, a causa del suo reddito modesto, il barattolo di pelati più economico; se i cestini straripano di rifiuti non è colpa delle aziende privatizzate che ne pospongono lo svuotamento ma di chi non è stato abbastanza virtuoso da tenersi in tasca il cestino appiccicoso del gelato.
In altre parole: qual è la priorità, quella di adeguare la sanità al – peraltro già noto da tempo – rischio di pandemia o quella di abituarci a reiterati lockdown gettando al contempo la croce sui comportamenti individuali?
10. Residuo organico
Scrive Elisa Melonari su Jacobin:
«Arrivati a questo punto ci si chiede “quanto durerà ancora?”, “fino a quando dovremo evitare il contatto?”, “per quanto ancora si dovrà rimanere isolati e lasciarci consolare da saluti, abbracci e baci virtuali?”, “per quanto ancora potremmo riuscire a non incontrarci, riunirci, cooperare e parlare vis a vis?” e “se non ci ammaleremo, come usciremo da questa vicenda?”. La risposta temporale continua a non essere del tutto sicura.»
Probabilmente la paura, l’isolamento e il confinamento di queste settimane ci lasceranno in eredità problemi accresciuti di alcolismo (qui alcuni dati britannici) e tabagismo (non ho trovato dati, ma visto che «comprare le sigarette» è uno dei pochi validi motivi per uscire…). Si producono inoltre effetti paradossali: da un lato il posticipo di un gran numero di prestazioni mediche per altre patologie (che ovviamente avrà conseguenze), dall’altro la preoccupazione di molti nel recarsi nei luoghi di cura. Questa seconda tendenza ha raggiunto dimensioni misurabili, che si esprimono nel corposo e «misterioso» calo degli infarti registrato da più parti, costituito in realtà da infarti i cui sintomi vengono «volutamente ignorati» per evitare di andare in ospedale, «rischiando così di aggravare la propria situazione».
Per interrompere una spirale di solitudine e malessere, una spirale da cui peraltro il vero punto della pandemia – ovvero l’inadeguatezza del nostro sistema sanitario a farvi fronte – viene trascurato, abbiamo bisogno di tracciare un percorso che punti con certezza all’«incontrarci, riunirci, cooperare e parlare» di persona, con la prossimità dei corpi, anche se non è ancora possibile segnare una data sul calendario. Non possiamo e non dobbiamo stare ad ascoltare passivamente quelli che vorrebbero far penetrare irreversibilmente nel quotidiano la digitalizzazione spinta, le videoriunioni in cui si cerca conferma della propria esistenza controllando compulsivamente la propria immagine sullo schermo, il «distanziamento sociale» reso eterno e le sue disastrose conseguenze sociali.
–
Wolf Bukowski scrive su Giap, Jacobin Italia e Internazionale. È autore per Alegre di La danza delle mozzarelle: Slow Food, Eataly Coop e la loro narrazione (2015), La santa crociata del porco (2017) e La buona educazione degli oppressi: piccola storia del decoro (2019). Durante quest’emergenza coronavirus ha già scritto per Giap l’articolo in due puntate La viralità del decoro. Controllo e autocontrollo sociale ai tempi del Covid-19.

L’Eternauta, di Héctor Oesterheld e Francisco Solano López.
Postilla – di Wu Ming
«Abbiamo detto no all’attività motoria in generale non perché rappresenti il primo fattore di contagio ma perché volevamo dare il senso che il regime di restrizioni […] doveva essere molto severo e stringente.»

Davide Baruffi.
Così Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della regione Emilia-Romagna, in una dichiarazione del 22/04/2020. A riprova di quanto cerchiamo di dire da due mesi: molti provvedimenti erano «teatro politico» e poco più.
Baruffi lo ammette candidamente: vietare corse e passeggiate non aveva motivazioni razionali legate al contagio, ma finalità di disciplinamento, a prescindere dalla pericolosità o innocuità dell’attività vietata.
Il 27 aprile, mentre genitori, esponenti della chiesa cattolica, insigni giuristi non certo “sovversivi” e in generale cittadine e cittadini criticavano l’impostazione autoritaria e «Fabbrica, patria, famiglia» dell’ultimo Dpcm (il primo della sedicente «fase 2»), il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini criticava il decreto per altre ragioni, una delle quali ci è parsa rivelatrice: Bonaccini vorrebbe l’obbligo di mascherina anche all’aria aperta e si è detto deluso perché Conte non l’ha introdotto.
Repetita iuvant: la mascherina è necessaria se si è a contatto con contagiati o in situazioni di assembramento, ed è consigliata in negozi e altri spazi chiusi dove ci si ritrovi tra estranei. All’aria aperta, invece, se si mantengono le distanze, nella grande maggioranza delle circostanze non serve a nulla. Portarla mentre si cammina all’aperto lontani da chiunque non ha senso. Indossarla mentre si fa attività fisica è addirittura pericoloso.
Il numero di persone che usano la mascherina all’aria aperta è rapidamente aumentato dopo un bombardamento di articoli e servizi tv in cui si descriveva il virus come una minaccia genericamente «là fuori», si demonizzava l’aria aperta e si criminalizzava chi usciva di casa «senza motivo». Negli ultimi giorni, almeno a Bologna, il numero sembrava di nuovo calato, ed ecco che Bonaccini se ne esce con quelle frasi.
Nonostante i media abbiano fatto di tutto per inculcare questa credenza, il virus non è genericamente «là fuori nell’aria». Non è la neve del fumetto L’Eternauta e nemmeno la nuvola velenosa del romanzo La nube purpurea. Se il virus fosse genericamente «nell’aria», non si dovrebbe nemmeno stare alla finestra e men che meno al balcone – dove invece ci esortavano a stare per flash mob, cantate collettive e sventolar di bandiere – e dovremmo tenere gli infissi sbarrati 24 ore su 24. Per non morire, dovremmo smettere di vivere.
«Ma», obietterà qualcuno, «io ho letto che il virus viaggia sulle polveri sottili. Quindi, sì, è nell’aria!»
Non è proprio così. Su alcuni campioni di PM10 raccolti a Bergamo si sarebbe «ragionevolmente dimostrata» la presenza non del virus attivo, ma di tracce del suo RNA. Residui privi di carica infettante, trovati in almeno 12 dei 34 campioni, in 8 delle 22 giornate prese in esame.
Questi risultati, che sono parzialissimi e devono passare al vaglio della comunità scientifica, sono ben lungi dal provare che il particolato sia vettore di contagio. Lo dice anche il team della Società di Medicina Ambientale che ha condotto le ricerche.
Una delle finalità dichiarate è usare la presenza di RNA virale nel particolato come «indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del Coronavirus e adottare adeguate misure preventive prima dell’inizio di una nuova epidemia», nonché «per verificar[e] la diffusione [del virus] negli ambienti indoor come ospedali, uffici e locali aperti al pubblico». Con motivazioni simili si stanno analizzando le acque reflue.
Il preprint da cui è nata la notizia si chiude così:
«Al momento, non si possono trarre conclusioni sul rapporto tra presenza del virus nel PM e andamento dell’epidemia di Covid-19. Altre questioni da affrontare in modo specifico sono le concentrazioni di PM eventualmente richieste per un potenziale “effetto boost” sul contagio nelle aree dove l’impatto del covid-19 è più pesante, o anche la possibilità teorica di un’immunizzazione conseguente all’esposizione in dosi minime a basse quantità di PM».
Sui media tutte queste specificazioni e cautele passano in secondo piano o scompaiono, oscurate da titoli come: «È ufficiale, il coronavirus viaggia nel particolato atmosferico!». Il lettore medio non può che pensare al virus attivo, e ricavarne l’impressione che per contagiarsi basti tout court respirare, che stare all’aperto sia pericoloso.
Pericoloso può esserlo senz’altro, nei centri urbani, ma più che per il virus, per il particolato stesso. Molti che oggi sono terrorizzati dal virus non si sono mai preoccupati granché delle polveri sottili, eppure queste ultime causano tumori, malattie respiratorie, disturbi neurologici, e solo in Italia uccidono circa 60.000 persone all’anno.
L’idea che il virus attivo possa viaggiare nell’aria è stata definita «implausibile» in un documento della Rete Italiana Ambiente e Salute firmato da diversi epidemiologi:
«Pur riconoscendo al PM la capacità di veicolare particelle biologiche (batteri, spore, pollini, virus, funghi, alghe, frammenti vegetali), appare implausibile che i Coronavirus possano mantenere intatte le loro caratteristiche morfologiche e le loro proprietà infettive anche dopo una permanenza più o meno prolungata nell’ambiente outdoor. Temperatura, essiccamento e UV danneggiano infatti l’involucro del virus e quindi la sua capacità di infettare.»
Di questo virus non sappiamo ancora tutto. Ma di quel che già sappiamo, nulla può fare da pezza d’appoggio per l’obbligo generalizzato di mascherina.
Ancora una volta si invocano o introducono obblighi e divieti non per ragioni epidemiologiche, non basandosi su evidenze scientifiche, ma per questioni di spettacolo sociale e controllo dei comportamenti delle persone. Bisogna far vedere che si soffre; bisogna ostentare la “penitenza” che gli italiani starebbero scontando; dovremmo «dare il senso di» un distanziamento che è qui per rimanere, «abituarci» all’idea di non avere più contatti ravvicinati.
Come fa notare Wolf nell’articolo qui sopra, un conto è parlare del distanziamento come di una necessità temporanea che tocca sopportare in attesa che la pandemia finisca; tutt’altra faccenda è dare per scontato che il distanziamento – con tanto di mascherina – sarà la condizione permanente del nostro vivere.
Certi improbabili “futurologi” descrivono, con inconfondibili brividi di piacere, una società che a noi, detta come va detta, fa schifo. Non ci rassegneremo ad alcun discorso, obbligo o divieto che ne favorisca l’accettazione.
da: https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/04/max-headroom-19-pandemia-e-societa-senza-corpi/



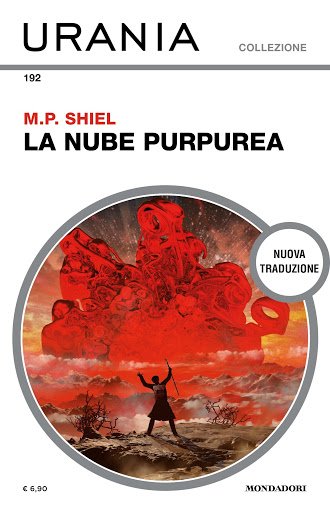


Leave a Comment