Non sono solo i modi paternalistici e terrorizzanti con cui la crisi pandemica viene gestita a dover essere messi in discussione. C’è da riconoscere e rifiutare quell’antico e profondo dominio di colonialismo, capitalismo e scienza che riduce l’autonomia delle persone e delle comunità per trasformare tutto in merce. È da quel dominio che nasce il contagio dell’idea di salute come prestazione tecnica indipendente dal contesto: sia ben chiaro, ci viene detto dall’alto, che il problema del virus e delle sue conseguenze è intrinsecamente nostro e nulla ha a che fare con l’organizzazione del mondo.
1.Cronache di una primavera e di un autunno
Nei primi giorni di maggio, sul finire della cosiddetta fase 1, in un lungo post intitolato Ammalarsi di paura, analizzavamo l’inaudita gravità della situazione lombarda con gli strumenti dell’antropologia medica e dell’etnopsichiatria e proponevamo di includere fra le concause di quel disastro anche l’effetto nocebo indotto dal «terrore a mezzo stampa». Come molti testi nati in quei mesi, anche quello, in qualche modo, si era scritto da sé in tempi rapidissimi, in una sorta di stato non ordinario di coscienza indotto dal trattenimento casalingo.
Subito dopo, la fase 2 ha portato nuove questioni, nuove angosce, un’enorme stanchezza e un diverso registro di visibilità. Lungo l’estate il moto emotivo collettivo è andato nella direzione di un certo oblio: sperando che tanto la pandemia quanto il governo fossero in remissione, non abbiamo avuto voglia di fare i conti con ciò che avevamo appena vissuto. Troppo faticoso da elaborare e poi il virus non c’è quasi più, pensiamo a ripartire…
Quando la storia attraversata è traumatica e carica di angoscia, può capitare, sia ai singoli che a intere collettività, di aver voglia di pensare ad altro e “guardare avanti”, nel tentativo ambiguo di alleviare il carico emotivo senza fare i conti con le responsabilità. Luca Casarotti ha descritto questo processo, per un tutt’altro momento storico, nel suo discorso per il 25 aprile 2018. Dal punto di vista psicologico si capisce bene il perché di questa strategia, che però, alla lunga, è fallimentare e collusiva. E infatti ora, in mezzo alla seconda ondata autunnale, ci ritroviamo con una società profondamente trasformata, con le piazze presidiate da Forza Nuova, con regolamenti più assurdi di quelli primaverili, con una sinistra più polverizzata e residuale che mai, con il malessere psichico alle stelle e con una miriade di schegge tossiche infilzate nell’immaginario – a partire da quelle emesse dalla «bomba a frammentazione psichica» detta QAnon.
Bisogna riprendere il filo. Con dieci mesi di emergenza alle (e sulle) spalle, ma, anche, con l’aiuto di una letteratura critica che comincia a sedimentare, proviamo a portare innanzi il discorso cominciato a maggio e a trarre alcune delle conclusioni che, a primavera, non sapevamo articolare – prima che nuove fasi-due/tre/quattro, o il dolce oblio che già i giornali vanno orchestrando, ci distraggano.
2. Sull’utilità della storia per la vita
O forse i fili da riprendere sono due. Uno, più specificamente italiano (e tuttavia estendibile ad altre situazioni), è immediatamente politico e riguarda i modi paternalistici, terrorizzanti e polizieschi con cui la crisi è stata gestita, la violenza istituzionale di cui un’emergenza sanitaria è stata caricata. Il secondo filo, molto più generale ma anche meno visibile, riguarda l’assetto antropologico dell’Occidente contemporaneo, la sua strutturazione materiale e simbolica, il modo in cui dà forma agli umani che lo abitano. I due fili s’intersecano e, per molti aspetti, la terra dell’eterna emergenza è un osservatorio privilegiato. Ma mentre il primo è già ampiamente analizzato (soprattutto in questa sede), il secondo è molto meno visibile, più elusivo e scivoloso. È possibile, però, che sia proprio questo filo a permettere di spiegare alcuni dei fenomeni più inquietanti di questo periodo e, in particolare, l’appiattimento degli ambienti della sinistra critica su posizioni filogovernative.

La prima domanda da farsi è dunque: come siamo arrivati fin qui? Cos’è dovuto succedere, prima del virus, perché potessimo così prontamente rinunciare alle libertà fondamentali, allontanarci da amori e affetti, sospendere istituti sociali primari (il saluto ai morti e quello ai nuovi nati, ad esempio), prendercela con il vicino, percepire la presenza del prossimo come minaccia letale, accettare ogni invasione dell’intimità e lanciare volontariamente i nostri figli in pasto al drago telematico? Che tipo di addestramento cognitivo ed emotivo è necessario perché una storia dell’orrore come quella di QAnon risulti diffusamente credibile? Che idea di corpo, di salute, di malattia, di benessere bisogna avere per pensare che i colpevoli di un evento pandemico possano essere i bambini o chi va a correre in spiaggia? Si tratta, insomma, di capire come è stata costruita la soggettività contemporanea, lungo quali assi pulsionali, affettivi e cognitivi; quali sono i suoi presupposti; quale il suo “regime di veridizione” e i valori che la costituiscono.
Richiamiamo telegraficamente il quadro concettuale nel quale ci muoviamo, che il post di maggio articolava in modo più approfondito. Quando in antropologia si dice che un fenomeno è sociale, non s’intende affatto che esso sia di minor rilievo rispetto a un qualsiasi fenomeno di natura, perché non esiste fatto di natura – neanche il funzionamento del nostro genoma – che non sia preso fin dall’inizio in un intrico di relazioni e scambi, in un certo tempo, in una storia collettiva. Detto altrimenti: gli umani sono storici fin dall’inizio e fin nel profondo, vivono e muoiono delle verità messe a disposizione dal loro mondo e a esso, in larga parte e inconsapevolmente, si conformano. Se non lo facessero, non potrebbero abitarlo. Anche ciò che sembra più intimo e intangibile – la soggettività, il fatto di percepirsi come persone fatte così-e-così – è storica: dipende dagli assetti ontologici, culturali, economici, simbolici di un mondo umano; dalla distribuzione del potere che vi si pratica; dal tipo di rapporti ammessi e non ammessi. Solo conoscendo almeno un po’ questi presupposti si può prender parte e provare a modificare l’assetto: i tentativi di agire su un mondo culturale, e su se stessi in quanto elementi di quell’orizzonte, non possono che partire da un’apprensione critica dell’acqua in cui si nuota – apprensione faticosa, perché rivela le proprie collusioni e richiede una certa disponibilità alla trasformazione.
È dunque proprio nella storia recente e nei suoi presupposti che dobbiamo cercare le cause della trappola emotiva, concettuale, etica e politica nella quale, oggi, siamo presi. Se siamo così malmessi, non è per via di un destino ineludibile o di immutabili leggi di natura, ma a causa di ciò che è successo ai singoli e ai collettivi, dell’organizzazione delle nostre vite, dell’insieme di convinzioni e costrizioni che regolano i nostri giorni. Per via di un insieme di fattori che, se conosciuti, si può almeno provare a controeffettuare. In questo post ci concentreremo sull’idea di individuo e di salute di cui tutti, in quanto occidentali contemporanei, siamo in qualche misura portatori. Ancora una volta, chiediamo a chi legge una certa pazienza.
3. Esproprio
Nella sua forma egemone, la modernità è il mondo umano che ha preso forma in Europa, fra Cinquecento e Settecento, nella coalescenza di tre giganteschi processi storici: colonialismo, capitalismo e scienza. Senza l’oro, la manodopera e le sperimentazioni schiavistico-industriali delle colonie non ci sarebbe stata l’accumulazione primitiva. Senza la piega antropologica del protestantesimo, l’accumulazione primitiva non avrebbe innescato il circuito del plusvalore e la transizione al capitalismo. Senza la Scienza – intesa qui, al singolare e con la maiuscola, come «unico regime legittimo di veridizione» e poi come deriva scientista – non sarebbero state possibili l’oggettivazione del mondo, la giustificazione delle nuove gerarchie globali e il mito del progresso. Il convenire di questi tre fenomeni ha dato origine al potente dispositivo di centralizzazione e omogeneizzazione necessario al suo funzionamento (lo Stato nazione) e al tipo di soggettività richiesta dalla nuova configurazione (l’individuo).
Utopia del progresso e violenza del dominio vanno osservati insieme. Se da un lato la modernità si presenta come la realtà radiosa di un mondo di conoscenza, ricchezza, democrazia, libertà, salute e comodità tecnicamente assistita, dall’altro è costretta a occultare continuamente la violenza del plusvalore e di ciò che lo fa girare, e cioè l’esproprio. Marx ha descritto in pagine celebri l’esproprio dei produttori dai mezzi di produzione, battezzando questo processo «accumulazione originaria»: la sua violenza ha distrutto ogni modo altro di organizzazione, separando i soggetti fra loro e dall’insieme ecologico del loro mondo.
A partire da questa operazione di disvelamento, altri espropri sono diventati osservabili: quello coloniale, con l’appropriazione delle terre e l’ecatombe delle popolazioni; quello dei saperi autonomi dei collettivi umani, con i roghi delle streghe e l’instaurazione di un regime di “verità accademica”; quello delle conoscenze agricole con le piantagioni; quello del tempo di vita e delle capacità produttive con la disciplina di fabbrica; quello dei corpi, con la riduzione di quello maschile a macchina produttiva e di quello femminile a macchina da riproduzione e ricreazione; quello delle viscere del pianeta con l’estrattivismo; quello di apprendimento e invenzione tramite disciplinazione istituzionale; quello degli affetti tramite un patriarcato particolarmente crudele; e quello della qualità politica dell’esistenza umana con il totalitarismo e i campi. L’insieme di questi processi mira alla riduzione, e poi alla sparizione, dell’autonomia dei soggetti e dei collettivi in vista della traduzione di tutto ciò che costituisce la vita umana in merci o servizi acquistabili – e cioè, raggiungibili solo tramite la mediazione del denaro. La stessa esistenza soggettiva diventa un bene espropriabile.
4. Il soggetto monadico della modernità
Quest’immane processo di immiserimento ha avuto ripercussioni profonde sulla soggettività, sul modo in cui dev’essere costruita per risultare conforme alle mutate condizioni sociali. Il soggetto della modernità occidentale è l’individuo autonomo che tutti quanti, da quattro secoli, siamo tenuti a essere, il personaggio ideale ipotizzato dal diritto, dall’economia e dal grande romanzo dell’età borghese: auto-centrato, autosufficiente, nel pieno possesso delle sue capacità razionali, in stato di veglia, identico a sé; che trova in sé – e non nelle relazioni, nel cosmo, negli antenati – la propria ragion d’essere; che non considera le relazioni come parte fondante della propria identità e idealizza la sua interiorità come unico luogo dell’intenzione e della civiltà, squalificando sistematicamente tutti coloro che non la possiedono nelle sue stesse forme (gli animali “privi di anima”, le donne “istintive e poco razionali”, i bambini “umani dimidiati”, i non-europei “selvaggi e incivili”, i dormienti “pigri”, gli psiconauti “criminali”).
 Come ha argomentato David Graeber, l’individuo moderno eredita dalla sovranità dei re un certo grado di privilegio utopico: gode del benessere prodotto da condizioni strutturali che obbligano altri a lavorare per lui; dispone di un altissimo potere di accesso alle forze che governano la vita sulla terra – soldi, passaporto, medicinali, gadget tecnologici – e non è legato da vincoli di reciprocità. Il primo punto richiede forse un chiarimento: come notato dai femminismi, l’individuo teorizzato dalla modernità è, in primo luogo, maschio, bianco e benestante; gode quindi dei privilegi che derivano dalla strutturazione patriarcale, coloniale e di classe. Le lotte sociali hanno democratizzato alcuni di questi vantaggi a una fascia più ampia dei cittadini dell’occidente, ma senza eliminare del tutto la violenza che li sottende – una violenza globale che sarebbe ipocrita non osservare: se possiamo far benzina ai nostri mezzi a motore, è perché le comunità amazzoniche pagano il prezzo ecologico dell’estrazione di petrolio; se a Natale possiamo comprare ai nostri figli, per pochi euro, grossi giocattoli di plastica, è perché le operaie uccise nelle maquilladoras messicane ne hanno già pagato il prezzo; e via dicendo.
Come ha argomentato David Graeber, l’individuo moderno eredita dalla sovranità dei re un certo grado di privilegio utopico: gode del benessere prodotto da condizioni strutturali che obbligano altri a lavorare per lui; dispone di un altissimo potere di accesso alle forze che governano la vita sulla terra – soldi, passaporto, medicinali, gadget tecnologici – e non è legato da vincoli di reciprocità. Il primo punto richiede forse un chiarimento: come notato dai femminismi, l’individuo teorizzato dalla modernità è, in primo luogo, maschio, bianco e benestante; gode quindi dei privilegi che derivano dalla strutturazione patriarcale, coloniale e di classe. Le lotte sociali hanno democratizzato alcuni di questi vantaggi a una fascia più ampia dei cittadini dell’occidente, ma senza eliminare del tutto la violenza che li sottende – una violenza globale che sarebbe ipocrita non osservare: se possiamo far benzina ai nostri mezzi a motore, è perché le comunità amazzoniche pagano il prezzo ecologico dell’estrazione di petrolio; se a Natale possiamo comprare ai nostri figli, per pochi euro, grossi giocattoli di plastica, è perché le operaie uccise nelle maquilladoras messicane ne hanno già pagato il prezzo; e via dicendo.
C’è però un lato in ombra: se il sovrano è, per definizione, un uomo solo, soli saranno anche tutti i “sovrani di stessi”. In-dividuo significa “ciò che non può essere ulteriormente diviso”: i soggetti moderni sono tenuti a essere monadi, a vivere quanto più possibile in assenza di relazioni orizzontali, godendo di ciò che riescono ad accaparrare per sé in un mondo descritto, e quindi costruito, come inospitale, lotta di tutti contro tutti sullo sfondo di una natura matrigna che non dà mai a sufficienza. A verifica di questo mito fondante si possono rileggere le pagine iniziali di un qualunque manuale di economia. Fra gli umani si crea il vuoto: lo Stato e il mercato organizzano gli individui in quanto già separati, strappati dalla tessitura relazionale della vita; dal mondo scompaiono i fili che uniscono ciò che esiste in trame ecologiche di senso, rimpiazzati da un unico, invisibile cavo d’acciaio che vincola ciascuno al denaro e al mercato. La ricchezza di un individuo è l’insieme di tutte le cose che può fare senza negoziarle con altri; quest’assenza di legami è detta libertà.
 Per questo soggetto, l’isolamento dal mondo è al contempo protezione dai pericoli e legittimazione all’indifferenza. Sicuro del proprio prestigio (ben esemplificato da quello dei cittadini civilizzati rispetto ai barbari e ai selvaggi) e tecnicamente potenziato, forte della sua relazione con il denaro, depositario unico della coscienza, della conoscenza, dell’intenzione e del senso, l’individuo moderno è solipsistico. La regolazione dei rapporti fra soggetti non è pensata come un’interconnessione ma nei termini del diritto, e il diritto è solo dell’individuo (come dimostra la difficoltà di garantire protezione alle «persone non umane», la sordità dei giuristi al diritto delle comunità e lo stallo, individuale e istituzionale, che sperimentiamo di fronte a soggetti costruiti in modo diverso da noi).
Per questo soggetto, l’isolamento dal mondo è al contempo protezione dai pericoli e legittimazione all’indifferenza. Sicuro del proprio prestigio (ben esemplificato da quello dei cittadini civilizzati rispetto ai barbari e ai selvaggi) e tecnicamente potenziato, forte della sua relazione con il denaro, depositario unico della coscienza, della conoscenza, dell’intenzione e del senso, l’individuo moderno è solipsistico. La regolazione dei rapporti fra soggetti non è pensata come un’interconnessione ma nei termini del diritto, e il diritto è solo dell’individuo (come dimostra la difficoltà di garantire protezione alle «persone non umane», la sordità dei giuristi al diritto delle comunità e lo stallo, individuale e istituzionale, che sperimentiamo di fronte a soggetti costruiti in modo diverso da noi).
Si comprende meglio la logica del soggetto-individuo mettendola a confronto con quella del soggetto-dividuo descritto dall’antropologia, che si pensa a partire dalle relazioni che lo costituiscono, snodo di fili che originano altrove e che sono intrinseci e definitori di sé. Individualità e dividualità non esistono da nessuna parte in forma pura, sono poli ideali di un variegato campo di possibilità: perfino da noi, dove la strutturazione individuale è arrivata al grado più estremo, parti cruciali dell’esperienza sono meglio descritte come dividuali. Èil caso della parentela, persone «fatte della stessa sostanza».
Sta di fatto che lo sforzo per produrre individui è stato titanico: ci sono voluti secoli di potere disciplinare e di alienazione per separare gli umani fra loro e dai legami che danno senso alla vita, fino a ottenere soggetti abbastanza induriti da raggiungere gli altri solo tramite la mediazione invisibile del mercato; di raggiungerli, cioè, come merci o tutt’al più come partner d’impresa. In primo luogo, come visto, li si deve isolare; poi occorre mantenerli separati, impedendo che i legami si ricostituiscano. Applicata dapprima per disarticolare i mondi esistenti, la violenza viene poi impiegata per evitare la ricomposizione degli umani in collettivi che abbiano la pretesa di autodeterminarsi (le fasi di crisi del lavoro sono, da questo punto di vista, esemplari). E poiché gli umani tendono comunque a stabilire fra loro relazioni e vincoli di reciprocità che li muovono verso piste imprevedibili, bisogna intercettare e flettere questo movimento prima che prenda forma, fornendo a compenso i benefici che vengono dell’organizzazione coloniale dello sfruttamento e l’utopia di una vita senza dolore.
5. La salute come prestazione tecnica
La separazione dei produttori dai mezzi di produzione e l’erosione dell’autonomia di singoli e collettivi riguarda anche la salute. Nelle società a organizzazione non moderno-statale le conoscenze relative alla salute di base appartengono di solito alla collettività nel suo insieme. Le pratiche igieniche per non ammalarsi, il trattamento delle affezioni più comuni, l’impiego delle erbe medicinali e un certo “sapere del corpo” sono competenze diffuse, così come la capacità di prendersi cura dei neonati, dei bambini, degli infermi, degli anziani e dei morenti. Questo significa che la maggior parte della vita si svolge entro margini ampi di competenza e senza bisogno di delegarla a prestatori d’opera professionali. In questi contesti i terapeuti sensu strictu – e cioè coloro che detengono conoscenze più approfondite e competenze tecniche specifiche sulle malattie e sulle cure – vengono mobilitati soprattutto per le crisi che non si riesce a risolvere a livello di presa in carico comunitaria.
 A scanso di equivoci, non stiamo argomentando in favore di forme di primitivismo: il punto non sono i mezzi, più o meno sofisticati, di cura, ma la distribuzione delle competenze. Non a caso, nel fermento sociale, culturale e istituzionale degli anni Settanta, la qualità comunitaria della salute e il suo controllo democratico erano al centro della riflessione di molti movimenti antagonisti rivoluzionari, fra cui le Black Panthers; allo stesso modo, la più epocale dichiarazione programmatica dell’ONU – quella di Alma Ata del 1978, che al punto 4 recita «le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla progettazione e alla realizzazione dell’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno» – prendeva a modello l’esperienza cinese dei medici scalzi per promuovere la salute comunitaria.
A scanso di equivoci, non stiamo argomentando in favore di forme di primitivismo: il punto non sono i mezzi, più o meno sofisticati, di cura, ma la distribuzione delle competenze. Non a caso, nel fermento sociale, culturale e istituzionale degli anni Settanta, la qualità comunitaria della salute e il suo controllo democratico erano al centro della riflessione di molti movimenti antagonisti rivoluzionari, fra cui le Black Panthers; allo stesso modo, la più epocale dichiarazione programmatica dell’ONU – quella di Alma Ata del 1978, che al punto 4 recita «le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla progettazione e alla realizzazione dell’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno» – prendeva a modello l’esperienza cinese dei medici scalzi per promuovere la salute comunitaria.
A questa prima lezione antropologica su come le risorse di salute possano essere diversamente distribuite, se ne deve aggiungere una seconda, cruciale, sull’ecologia della salute. Ogni collettivo umano vive in profonda simbiosi, e in un rapporto di co-produzione reciproca, con ciò che chiamiamo “ambiente”: arie, acque, terre, viventi non-umani, ma anche milieu psichico, affettivo, cognitivo, miti, sogni e via dicendo. L’ambiente non è qualcosa di esterno, uno sfondo ostile o accogliente, un parco da colonizzare, ma l’esito di un modo di vivere e di stare in relazione fra umani e non-umani. L’autonomia e le risorse di salute dei collettivi si misurano anche sulla possibilità di intervenire sul proprio ambiente quando questo diventa patogeno – ovvero, di modificare le proprie pratiche e il proprio assetto di vita per mantenere o ripristinare la salute.
Tutto ciò viene profondamente minato dall’avvento della modernità, a partire dall’esproprio “originario” della terra, che distrugge un termine ecologico fondamentale, passando per l’imposizione del medico accademico come sola figura legittimata al gesto terapeutico, fino alla medicalizzazione integrale della vita (si pensi, ad esempio, al parto ospedaliero, alla delega al pediatra delle competenze genitoriali, alla morte in strutture dedicate, alla patologizzazione della devianza e dell’improduttività). Espropriati soggetti e comunità della possibilità di agire sull’ambiente, delle basilari competenze di salute primaria e della presa sui diversi momenti dell’esistenza, l’unica risorsa di salute disponibile è quella professionale e statale. La “via tecnica” alla salute diventa parte integrante del pacchetto del progresso e delle battaglie per la ridistribuzione sociale delle ricchezze.
«Una società industriale avanzata genera malattia perché rende gli uomini incapaci di controllare il proprio ambiente e, quando essi crollano, sostituisce una protesi «clinica» alle relazioni spezzate. Contro un simile ambiente gli uomini si ribellerebbero se la medicina non spiegasse il loro scombussolamento biologico come un difetto della loro salute, invece che come un difetto del modo di vivere che viene loro imposto (…). L’assicurazione di personale innocenza politica che la diagnosi offre al paziente serve come una mascherina igienica che giustifica un ulteriore asservimento alla produzione e al consumo.» (Ivan Illich, Nemesi medica, p. 174-175)
In parallelo ai processi di esproprio dei mezzi di salute e di statalizzazione e tecnicizzazione della medicina, l’origine della malattia si sposta sempre più verso l’interno dell’individuo: da esito di una certa configurazione ecologica e sociale (e parte ineludibile dell’umana finitudine), la malattia diventa un disfunzionamento privato, una falla nel funzionamento interno – meccanico, chimico, psichico – del soggetto, da affidare alle competenze certificate di un professionista e alla mano provvidenziale dello Stato. La morte stessa si fa impensabile: il soggetto della modernità ne è terrorizzato perché essa annulla il solo senso esistenziale possibile, quella della sopravvivenza individuale, del dominio sulle cose e del godimento; anch’essa, dunque, è stata progressivamente sottratta alla lavorazione culturale collettiva e affidata alle cure degli specialisti.
6. Capitale-salute
 Iniziati con la coppia Thatcher/Reagan e con la sconfitta del “decennio Sessantotto”, gli ultimi quarant’anni hanno portato la desertificazione relazionale e la guerra di tutti contro tutti fino a ciò che oggi chiamiamo “antropocene”. A partire dagli anni Ottanta la riconfigurazione neoliberista delle società occidentali ha comportato un’ulteriore stretta sulla soggettività. All’individuo razionale, autocentrato, competitivo e libero di muoversi nel mercato, richiesto dalla modernità capitalista, la governance neoliberista ha aggiunto capacità di auto-imprenditoria, trasparenza rispetto ai meccanismi di controllo, completa interiorizzazione delle leggi del mercato e disponibilità totale alla messa a profitto della propria vita (tramite lavoro salariato, consumo, soggezione burocratica, pubblicizzazione del privato e via dicendo). In tal modo, ha creato nuovi territori vergini da mettere a valore: dopo la colonizzazione delle terre, del tempo e dei viventi, ha trasformato anche l’interiorità dei soggetti in terra nullius passibile di appropriazione e sfruttamento, esattamente come i commons sui quali vivevano i contadini britannici o le ore della giornata lavorativa.
Iniziati con la coppia Thatcher/Reagan e con la sconfitta del “decennio Sessantotto”, gli ultimi quarant’anni hanno portato la desertificazione relazionale e la guerra di tutti contro tutti fino a ciò che oggi chiamiamo “antropocene”. A partire dagli anni Ottanta la riconfigurazione neoliberista delle società occidentali ha comportato un’ulteriore stretta sulla soggettività. All’individuo razionale, autocentrato, competitivo e libero di muoversi nel mercato, richiesto dalla modernità capitalista, la governance neoliberista ha aggiunto capacità di auto-imprenditoria, trasparenza rispetto ai meccanismi di controllo, completa interiorizzazione delle leggi del mercato e disponibilità totale alla messa a profitto della propria vita (tramite lavoro salariato, consumo, soggezione burocratica, pubblicizzazione del privato e via dicendo). In tal modo, ha creato nuovi territori vergini da mettere a valore: dopo la colonizzazione delle terre, del tempo e dei viventi, ha trasformato anche l’interiorità dei soggetti in terra nullius passibile di appropriazione e sfruttamento, esattamente come i commons sui quali vivevano i contadini britannici o le ore della giornata lavorativa.
Anche questo processo è noto e ormai ben descritto nei suoi effetti: dall’erosione del sonno all’aumento esponenziale di bullshit jobs, dal ruolo dei big data nel controllo alla diffusione a tappeto di sostanze, legali e illegali, che adattano i soggetti alla continua richiesta di prestazione (a scuola, sul lavoro, nello sport, nel gaming, sui social, a letto). L’esito scontato è l’innalzamento del malessere psichico e un livello ormai epidemico di disturbi depressivi e di ansia.
L’idea di salute si è ulteriormente ristretta: da qualcosa che lo Stato, bene o male, è tenuto a garantire ai cittadini, a un capitale individuale da far fruttare. Come il conto in banca, il raziocinio e l’autonomia, anche il benessere dei soggetti non è più questione politica ma pertinenza del singolo, un bene ontologicamente individuale che dipende esclusivamente dal proprio buon funzionamento interno. Se sei fortunato, nasci con una solida proprietà che potrai far fruttare in una lunga vita di salute e produttività; se sei uno come molti, hai in dotazione un piccolo patrimonio che ti conviene non sprecare; se nasci con un capitale-salute scarso… beh, peccato! Buttarti giù dal Taigeto ormai pare brutto e quindi, con gli ultimi residui di stato sociale, ti assisteremo in quanto categoria svantaggiata – ma sia ben chiaro che il problema è intrinsecamente tuo e nulla ha a che fare con l’organizzazione del mondo.
La salute diventa – come tutto, del resto – un gruzzoletto, un valore di scambio che partecipa alla solvibilità individuale (v., ad esempio, il modo in cui assicurazioni sanitarie possono accettare o rifiutare i possibili assicurati) e, quindi, ad assegnare una posizione nella gerarchia sociale. E poiché, per un individuo siffatto, null’altro dà senso al mondo se non il mero fatto di restare in vita per godere dei propri privilegi di consumatore e di cittadino del primo mondo, è chiaro che qualsiasi cosa metta a rischio questa condizione viene vissuto come una grave minaccia personale.
Qui eravamo quando, nel mese di febbraio dell’anno duemilaeventi, la diffusione di un agente patogeno di pericolosità media, unita al terrorismo mediatico e a misure contenitive di tipo poliziesco, ha mostrato con chiarezza esemplare l’esito politico, sociale e antropologico di questi processi. È qui che ora dobbiamo addentrarci.
7. Quod erat demostrandum
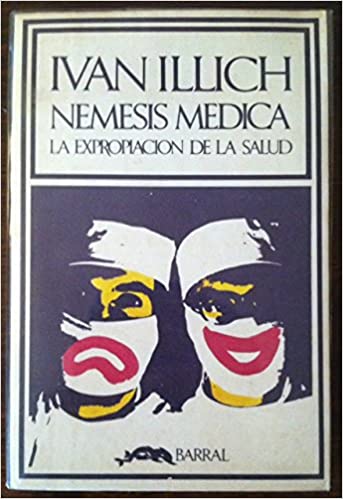 Riletto oggi, Nemesi medica di Ivan Illich fa l’effetto di una doccia scozzese: dapprima sollievo («finalmente qualcuno che mette in fila le cose!»); poi una serie di grattate dolorose alla sensibilità corrente (ad esempio le notazioni sulla patogenicità del sistema medico); e infine una sorta di vertigine quando ci si accorge che, a metà degli anni Settanta, concetti che oggi suscitano scandalo erano moneta corrente. La sua lezione più importante si può forse riassumere così: nessun punto della “macchina”, per quanto marginale, può essere cambiato senza modificare il sistema nel suo complesso. Da quanto tempo non si sentiva niente del genere…
Riletto oggi, Nemesi medica di Ivan Illich fa l’effetto di una doccia scozzese: dapprima sollievo («finalmente qualcuno che mette in fila le cose!»); poi una serie di grattate dolorose alla sensibilità corrente (ad esempio le notazioni sulla patogenicità del sistema medico); e infine una sorta di vertigine quando ci si accorge che, a metà degli anni Settanta, concetti che oggi suscitano scandalo erano moneta corrente. La sua lezione più importante si può forse riassumere così: nessun punto della “macchina”, per quanto marginale, può essere cambiato senza modificare il sistema nel suo complesso. Da quanto tempo non si sentiva niente del genere…
Il neoliberismo ha portato un’eclissi durevole dei guadagni teorici dei due decenni precedenti e reso quasi inascoltabili le parole di quell’epoca. E, soprattutto, ha parcellizzato e individualizzato processi e relazioni fino a polverizzare gli sguardi e le possibilità critiche: anche presso i soggetti più attenti, capaci di cogliere le storture e disposti a lottare per questa o quella causa, il quadro d’insieme risultava spesso inafferrabile.
Ora l’«evento-covid» arriva a sollevare il velo e rimette sotto gli occhi di tutti la profonda discrasia sistemica in cui viviamo – discrasia che non è stata causata dal virus: era già lì, ma non riuscivamo più a coglierla. La si può descrivere come la distanza che intercorre fra le esigenze del capitale e quelle degli umani (e degli altri viventi, e della terra). Il nostro mondo è ben organizzato secondo una logica di massimizzazione del profitto che mette tutto a servizio del plusvalore e si traveste, in circostanze ordinarie, da migliore dei mondi possibili. Finché le cose più o meno funzionano come ci aspettiamo, è difficile rendersi conto della qualità non-umana del suo assetto. È in circostanze non ordinarie, quando la logica umana di cura e solidarietà non può più essere aggirata, che ci si accorge di essere intrappolati nel letto di Procuste della logica del profitto, vincolati a una macchina che, dal punto di vista dell’umana esistenza, è completamente illogica. La logicità del sistema rispetto al profitto, e la sua illogicità rispetto alla vita, spiega la contraddittorietà del panorama che abbiamo di fronte ed è ciò che dobbiamo portare a tema in tutte le circostanze possibili.
Proviamo allora, in primo luogo, a tirar fuori dalla cantina i vecchi strumenti della teoria critica e a usarli per analizzare la pandemia in corso.
L’impostazione totalizzante e “oggettificante” della medicina high tech ha cominciato a essere percepita con inquietudine dai suoi stessi beneficiari: questo spiega, in parte, il fatturato delle medicine cosiddette «complementari e alternative». Sarebbe erroneo, però, tanto ridurre le perplessità dei pazienti a mistica new age, quanto non avvedersi che, su entrambi i fronti, gli operatori che davvero promuovono la salute e le capacità soggettive e comunitarie di prevenzione, cura e guarigione, non sono molti. Interessi corporativi, schiacciamento burocratico, pressioni industriali e puro e semplice profitto spesso hanno la meglio.
La concentrazione delle risorse di salute in macrostrutture dotate di tutti i macchinari di ultima generazione, a scapito della loro diffusione, è dannosa: non a caso, la centratura sugli ospedali, a detrimento dei presidi sanitari territoriali, è stata identificata fin dall’inizio della crisi come una delle cause principali del fallimento della sanità lombarda. Allo stesso modo, la produzione di plusvalore tramite la capitalizzazione dei bisogni di salute – nota anche come «privatizzazione della sanità» – ha rivelato durante l’epidemia tutta la sua inefficienza e il suo tasso di “perversione strutturale”. (In relazione alla Lombardia si veda, ad esempio, quest’intervista a un insider; ancora a scanso di equivoci, poiché la salute è sempre una faccenda collettiva, in discussione qui non è la sanità pubblica in quanto tale, ma la sua organizzazione, la sua catena di comando e la sua collusione con interessi economici contrari a quelli della salute globale.)

L’impossibilità di controllare il nostro ambiente giustifica il bisogno di tecnologie sofisticate per mettere una pezza sui mali derivanti dalla sua tossicità. A Taranto, dove la diffusione e la gravità delle malattie respiratorie dipende in modo palese dalle ciminiere dell’Ilva, è impossibile praticare l’arte medica senza prendere una posizione politica – senza agire in modo che i propri interventi terapeutici diventino, il prima possibile, superflui. Lo stesso vale oggi, mutatis mutandis, per lo stress che i territori più inquinati impongono al sistema respiratorio di chi li abita, come anche per la fragilità metabolica di popolazioni esposte a decenni di zucchero e junk food. Chi, in veste di terapeuta, voglia davvero curare i suoi pazienti, oggi non può fare a meno di interrogarsi politicamente sulle cause ambientali che precludono la guarigione e trasformano la terapia in mero controllo dei sintomi.
Se poi consideriamo la salute come un’ecologia di relazioni e ricchezza sociale a disposizione di una collettività (abitazioni decenti, ambiente non tossico, autonomia alimentare, socialità diffusa e affidabile, possibilità di agire positivamente sulla propria vita e su quella dei prossimi), allora lo stare in casa è, fra tutte, la misura più patogena che si potesse immaginare.
Quanto alla sottrazione della morte e del senso stesso della mortalità dalla presa dei soggetti, se essa non fosse già stata pressoché integrale prima della pandemia, immagini come quelle delle camionette dell’esercito che trasportano altrove le bare di Bergamo, o il divieto, decretato per legge, di assistere i propri anziani e i propri malati, sarebbero stati presi per quel che erano: violenze intenzionali, attacco ai legami fondamentali dell’umano vivere. La società contro lo Stato, scriveva Pierre Clastres – e viceversa.
8. Divide et impera
Fin qui le questioni sono di scelta politica e quindi, sia pure a fatica, articolabili. Messe sul tavolo, produrrebbero gruppi discordi, più o meno identificabili con una posizione sullo scacchiere, i quali, nel fronteggiarsi, si riconoscerebbero comunque come avversari legittimi. Altre partizioni sono più difficili da descrivere. Al contempo intime, meno legate all’appartenenza politica e più feroci negli effetti, hanno a che fare con gli effetti del neoliberismo sulla parte più profonda di noi, con la plasmazione inconsapevole a cui questi anni ci hanno esposti e con il nostro grado, consapevole e inconsapevole, di adesione.
Ligia ai dettami dell’individuo-monade, la stragrande maggioranza della nazione – inclusi molti di coloro che si atteggiano a critici del sistema – si è rivelata disposta a rinunciare alle proprie relazioni e a lasciarsi intrattenere entro le mura di casa; incline alla paranoia e alla difesa oltranzista del proprio gruzzoletto di salute; e nevrotica fino a prendere ogni perplessità come attacco personale e a raccogliersi minacciosa intorno a un nemico immaginario tacciato di “negazionismo”. La configurazione antropologica del neoliberismo è penetrata talmente a fondo da rendere uno stato sanitario di polizia più desiderabile del mondo nella sua interezza e della vita nella sua complessità.
Ancora una volta, si tratta di esproprio – e questa volta di tipo davvero particolare.
In linea con la necessità di creare sempre nuovi territori da mettere a valore, ciò a cui abbiamo assistito è un’innovativa applicazione dell’antico divide et impera. Oggi però la linea di divisione non è più solo quella che separa i soggetti e li isola, ma anche quella che divide i soggetti al loro interno. La paura, come la violenza, è una forza produttiva: perché possa agire, bisogna costringere i soggetti a ignorare i segnali in arrivo e a non concettualizzare quello che, pure, sentono chiaramente. I nostri corpi sanno benissimo che l’assenza di relazioni atrofizza il cuore e il cervello; che gli odori portati dai venti minacciano malattia; che l’insensatezza dei bullshit jobs diventa depressione; che d’estate non si può fare il bagno se il mare è cimitero – ma i nostri cervelli sono tenuti (e ben allenati) a rimuovere, razionalizzare, ignorare e disvedere. Se quel che sappiamo nelle cellule arrivasse a consapevolezza, l’impianto del dominio capitalista sarebbe in pericolo.
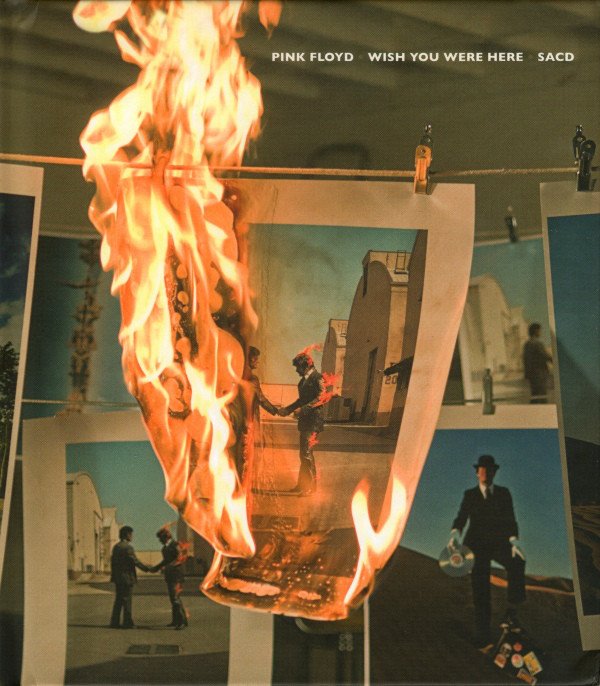 Di questa dissociazione coatta l’evento-covid ha dato la prova più piena e terribile che si potesse immaginare. Con il vecchio vocabolario marxista: ha mostrato che la sussunzione della vita e delle soggettività alle esigenze del capitale è (quasi) totale. A quarant’anni dall’inizio dell’offensiva neoliberista, la capacità collettiva di fare mondo e fare umanità, indispensabile nell’affrontare eventi eccezionali, è arrivata al suo minimo e pare integralmente delegata agli apparati dello Stato e dell’economia. Il cordone che ci lega a quel che resta della nostra traiettoria esistenziale (un tetto sopra la testa, la cittadinanza in una nazione europea, consumo e godimenti eterodiretti) ci impedisce di accorgerci che stiamo barattando la vita in cambio di una sopravvivenza neppure più “aumentata”; la gioia in cambio di godimenti tossici; la salute in cambio di uno stato di non-infezione. Soo-oo-oo, so you think you can tell… cantavano i Pink Floyd in un brano che, riascoltato oggi, fa male.
Di questa dissociazione coatta l’evento-covid ha dato la prova più piena e terribile che si potesse immaginare. Con il vecchio vocabolario marxista: ha mostrato che la sussunzione della vita e delle soggettività alle esigenze del capitale è (quasi) totale. A quarant’anni dall’inizio dell’offensiva neoliberista, la capacità collettiva di fare mondo e fare umanità, indispensabile nell’affrontare eventi eccezionali, è arrivata al suo minimo e pare integralmente delegata agli apparati dello Stato e dell’economia. Il cordone che ci lega a quel che resta della nostra traiettoria esistenziale (un tetto sopra la testa, la cittadinanza in una nazione europea, consumo e godimenti eterodiretti) ci impedisce di accorgerci che stiamo barattando la vita in cambio di una sopravvivenza neppure più “aumentata”; la gioia in cambio di godimenti tossici; la salute in cambio di uno stato di non-infezione. Soo-oo-oo, so you think you can tell… cantavano i Pink Floyd in un brano che, riascoltato oggi, fa male.
Il terrore del virus ha colpito molto al di sotto della zona cosciente delle nostre scelte e delle nostre opinioni; ha imperversato nella twilight zone dell’immaginario e dell’inconscio sociale, dove i tempi, la struttura sociale, la cosmovisione condivisa e gli eventi storici ci plasmano ben al di là della nostra consapevolezza. La questione cognitiva (chi vede il pericolo del virus non vede il pericolo politico, e viceversa) ha origine dalle diverse maniere in cui di ciascuno di noi è stato toccato, dal modo in cui abbiamo reagito “di pancia” alle paure indotte, da quanto ci siamo sentiti capaci di autonomia decisionale, dalla tenuta (o, viceversa, dalla fragilità) delle nostre relazioni, dall’affidabilità dei terapeuti di riferimento, dalla coerenza fra quel che pensiamo e come viviamo. Ha a che fare, quindi, con i fondamenti antropologici sui quali poggiamo i piedi, con le posizioni esistenziali più profonde, che non sempre corrispondono o sono armoniche con quelle dichiarate.
Impossibile sapere a priori dove ciascuno cadrà, come sentirà gli eventi, quali adesioni, collusioni e resistenze l’attraverseranno, così come non si può sapere a priori come i diversi soggetti si comporteranno nel pericolo o quale resistenza avranno al dolore. Per questo, come nella stasis (la guerra civile) greca, tutte le precedenti alleanze sono state annullate e messe alla prova degli eventi; per questo, anche, le fratture sono state così drastiche e dolorose: non avevano a che fare con le alleanze politiche, ma con qualcosa di molto più cruciale, con un’alleanza “esistenziale” che a volte, dove ci aspettavamo di trovarla, non c’era più. Spesso la reazione è stata di rabbia. È però possibile che, come suggeriscono le femministe statunitensi, la reazione appropriata sia piuttosto il lamento, il pianto di cordoglio: ancora un* altr* compagn* è stat* catturat*, un* altr* dei nostri reso impotente, un altro umano asservito a una logica non-umana.
9. Prender parte
Non c’è alcun bisogno di ipotizzare che quanto sta succedendo risponda a un piano qualchessia, dal momento che da sempre il capitalismo impiega le crisi – poco importa se piovute dal cielo o indotte – come volano. (E ad ogni modo, nell’orizzonte degli eventi detto “antropocene”, è ben difficile stabilire in che misura le epidemie siano esito di ricorrente sfortuna o effetto collaterale della distruzione ecologica.) Ma certo la risposta collettiva agli eventi ha dato preziose indicazioni a tutte le forze in campo che possono trarre vantaggio da un controllo ancor più stretto della popolazione. Bisogna muovere altrove con cortese urgenza.
Ci sono, per cominciare, una miriade di questioni politiche immediate su cui si sono mobilitati i diversi gruppi dell’attivismo nazionale, che da mesi discutono, si confrontano e avanzano proposte perfettamente sensate per intervenire sulla crisi in maniera meno raffazzonata, più equa e più efficace – per intervenire sulla scuola, sulla mobilità, sulle categorie professionali, sulla vita pubblica, sui territori e la distribuzione della ricchezza, in modo da ridurre collettivamente il rischio del virus senza trasformarci individualmente in zombie terrorizzati e terrorizzanti.
E poi c’è l’altro livello, quello del paradigma antropologico all’origine di questo disastro. Le ragioni per uscirne sono molte e di certo non sono nate quest’anno. La distruttività della moderna impresa capitalista, lo svuotamento di senso che essa induce, la violenza che infligge e l’infelicità che causa hanno cominciato a essere descritte fin dall’epoca del primo romanticismo; da Marx in poi, si può fare a meno di vederle solo accettando un certo grado di dissociazione. Oggi la dissociazione sembra un sine qua non per vivere nelle metropoli. E tuttavia, l’adozione intellettuale di posizioni critiche non basta: quanti raffinati decostruttivisti, quanti infervorati foucaultiani, quanti sublimi analisti delle “condizioni sociali” abbiamo visto, in questi mesi, ritirarsi spaventati sotto le gonne dello scientismo più becero all’insegna del “lasciamo che decidano gli esperti”, come se le epistemologie e le critiche sociali su cui hanno costruito le loro carriere fossero, in fondo, solo passatempi per gli anni di vacche grasse. È qui che, nei mesi scorsi, si è consumata la frattura fra posizione politica e posizione esistenziale. Certe posizioni politiche richiedono oggi una migliore tenuta dei fondamenti antropologici; altrimenti si finisce per cadere in quella che, negli anni Settanta, chiamavano critica-critica: un raffinato e sussiegoso ragionare al riparo dei propri privilegi di classe.
Non c’è stato solo questo, comunque – e per fortuna. A fronte dell’isteria maggioritaria, gli altri, quelli che sentivano il mondo in un’altra maniera, dapprima si sono sentiti pazzi. Poi hanno cominciato, ciascuno a suo modo, a reagire. C’è chi ha organizzato reti semiclandestine di preparazione e distribuzione di pasti; chi ha analizzato dati ed eventi in base alle proprie competenze; chi ha messo su gruppi di auto-aiuto; chi ha fatto vivere Giap. Molti oggi stanno pensando di andarsene dalle città e, fra i più giovani, la terra comincia a chiamare. Gruppi di lavoratori della sanità hanno veicolato analisi critiche e controproposte. La scuola è tornata a farsi sentire.

E poi bisognerebbe riflettere su quelli che, incapaci (a loro merito) di stare nell’ossessivo discorso maggioritario, ma drasticamente privi di strumenti critici, sono caduti (a loro rischio) in alter-narrazioni tossiche. Non sorprende, d’altronde, che dopo decenni di banalizzazione della lingua, di colonizzazione dell’immaginario e di guerra alla complessità, le più sciape storie dell’orrore possano suonare credibili. Da un certo punto di vista, questi nuovi “credenti” rappresentano una catastrofe e una fatica di Sisifo per chi, oltre a non stare nella narrazione maggioritaria, deve poi anche smarcarsi da questa galassia. Ma c’è qualcosa che va osservato e, se possibile, contattato: la qualità umana di chi trova così atroce quel che va accadendo, da ipotizzare che possa esser giustificato solo da qualcosa di altrettanto atroce.
Si tratta, ora, di prender parte: accettare il dolore che viene dal percepire il nostro mondo in tutto il suo disastro e la sua follia, osservare i punti in cui ha presa su di noi e organizzarsi con altri per immaginare (e fare esistere) modi diversi di stare al mondo. È qui che oggi è possibile costruire alternative al mondo-così-com’è con una radicalità che sembrava persa e a partire da una posizione del tutto marginale: quella di chi, nonostante tutto, continua a sentire il mondo in modo diverso da quello previsto; a non considerare il prossimo come una minaccia; a trovare che l’idea stessa di “salute individuale” sia un controsenso; a sentirsi attraversato e modificato da relazioni profonde con altri e altro; a non trovare la propria pienezza nel consumo o nell’accumulo; a provare sdegno di fronte alla violenza istituzionale e sistemica. Ne consegue la necessità di uscire consapevolmente dalla trappola dell’individuo atomico, del capitale-salute, della “sopravvivenza aumentata” e della dissociazione fra quel che sentiamo e quel che pensiamo. Di uscire, come ha scritto Avery Gordon in Ghostly matters, dalle ontologie della dissociazione e dalle epistemologie della cecità – impresa in cui cambiare il mondo e cambiare se stessi sono una sola e unica cosa.
_
Stefania Consigliere – ricercatrice all’università di Genova, dove insegna Antropologia e Antropologia dei sistemi di conoscenza, e dove coordina il Laboratorio Mondi Multipli, luogo di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche, epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di «prendere gli altri sul serio». Altre informazioni e articoli su: www.stefaniaconsigliere.it.
Cristina Zavaroni – antropologa culturale ed etnologa africanista, ha una lunga esperienza di ricerca presso i Bakonzo del Rwenzori in Uganda. Specializzata in antropologia cognitiva ed etnopsichiatria, lavora da diversi anni come consulente per l’Associazione Mamre Onlus di Torino. Dal 2013 fa parte del Laboratorio Mondi Multipli.
da Giap




Leave a Comment